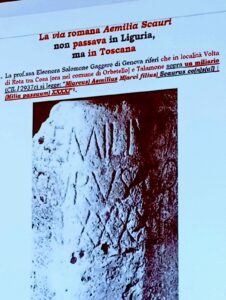Venerdì 19 aprile, alle ore 17, presso la Sala “Stella Maris” (piazza Rebagliati, Savona) Franco Icardi ha illustrato con dovizia di particolari le sue “”Ipotesi sul percorso della via “Iulia Augusta”, la principale strada romana della Liguria, da Vado (Vada Sabatia) ad Acqui (Aquae Statiellae), dalla Liguria verso Roma e la pianura padana”. Proprio nel Savonese, tra Quiliano e Cadibona, esistono infatti importanti resti di tale antica via di comunicazione (tuttora percorribile), compresi due ponti ancora ben conservati (sui quali passano tuttora veicoli), mentre si conservano e sono visibili i resti di altri tre ponti (un sesto ponte invece fu travolto e distrutto a inizio XIX secolo da una disastrosa piena del torrente Quazzola). Sabato 20 aprile c’è stato spazio per l’escursione “Alla scoperta dei ponti romani della via “Iulia Augusta” tra Quiliano e Cadibona”. Partenza alle ore 15 dal posteggio accanto all’ingresso del Camposanto di Savona. L’iniziativa (a cura di Nico Cassanello e Rinaldo Massucco) è stata organizzata dall’ Associazione “Aemilia Scauri”, dalla Società Savonese di Storia Patria e dal Gruppo Escursionistico “La Rocca”. Quattro anni or sono i ricercatori Cassanello, Massucco e Rosella Ricci avevano ritrovato quanto rimaneva del quinto ponte (il pilone idrografico sinistro del Rio Scarrone, affluente del torrente Quazzola, e parecchi resti delle arcate crollate), già segnalato nel secolo scorso, ma mai posizionato né fotografato e da quasi un secolo, fino al 2020, non più localizzato né visibile, avvolto da un intreccio inestricabile di rovi e macchia mediterranea e riportato oggi alla luce (insieme con i resti del quarto ponte, nel greto del Quazzola) grazie al prezioso e indispensabile lavoro della Pro Loco di Quiliano, con l’infaticabile e certosina opera di Filippo Minuto. I partecipanti hanno dovuto dotarsi di scarponcini da trekking che non lascino scoperte le caviglie, considerato che bisognava camminare per 100 metri in mezzo a spuntoni di rovi e arbusti vari lungo il percorso pulito alcuni mesi or sono, ma ora con vegetazione affiorante.
La Via Julia Augusta come detto è un’importante via romana che collegava Piacenza al fiume Varo, percorrendo le coste della Liguria e quelle della Costa Azzurra, in direzione del Rodano. Costituiva un ramo della via Aurelia e in pratica collegava la Gallia Cisalpina alla Gallia transalpina.Questa via è stata aperta poco dopo la conquista delle Alpi marittime contro le tribù liguri (nel 14 a.C.) dall’imperatore Augusto; essendo luglio e agosto i mesi dedicati rispettivamente a Giulio Cesare e ad Augusto, il nome dato a questa via riprende quello di tali imperatori. Il suo tracciato corrisponde ad un itinerario già esistente, ma una delle grandi imprese dell’Impero nascente è stata quella di restaurarla e segnarne il tracciato attraverso delle pietre miliari numerate da Roma. In stato di rovina all’inizio del II secolo è stata restaurata da Adriano e poi da Caracalla nel III secolo. La creazione di questa via ha portato alla fondazione di Cemenelum (Cimiez, colle di Nizza), capitale della provincia romana delle Alpi marittime. Il suo percorso iniziava a Placentia (Piacenza) e, passando per Iria (Voghera), Dertona (Tortona) e Aquae Statiellae (Acqui Terme), scendeva verso la costa e proseguiva fino al trofeo di Augusto de La Turbie, eretto dall’imperatore nel 7-6 a.C. fra Mentone e Nizza; solo successivamente fu prolungata fino ad Arelate (Arles), per collegarsi alla via Domitia (via Domizia). Lungo il suo tragitto attraversava, fra gli altri, i centri romani di Vada Sabatia (Vado Ligure), Albingaunum (Albenga) e Albintimilium (Ventimiglia). La Julia Augusta, in pratica, non era altro che il proseguimento del sistema viario già esistente via Aurelia/via Aemilia Scauri che fino ad allora terminava a Vada Sabatia; una volta completata, l’intera strada Aurelia-Aemilia-Augusta era lunga 962 km. Nel territorio ligure sono pochi i resti dell’antico tracciato individuabili: se ne trovano tra Albenga ed Alassio (brevi tratti del selciato originario) e nel finalese; più numerosi, invece, sono i ponti sopravvissuti (con alcune modifiche) fino ai nostri giorni, così come i monumenti funebri, visibili ad Albenga, e i cippi miliari, alcuni dei quali conservati presso il Museo civico archeologico Girolamo Rossi di Ventimiglia.